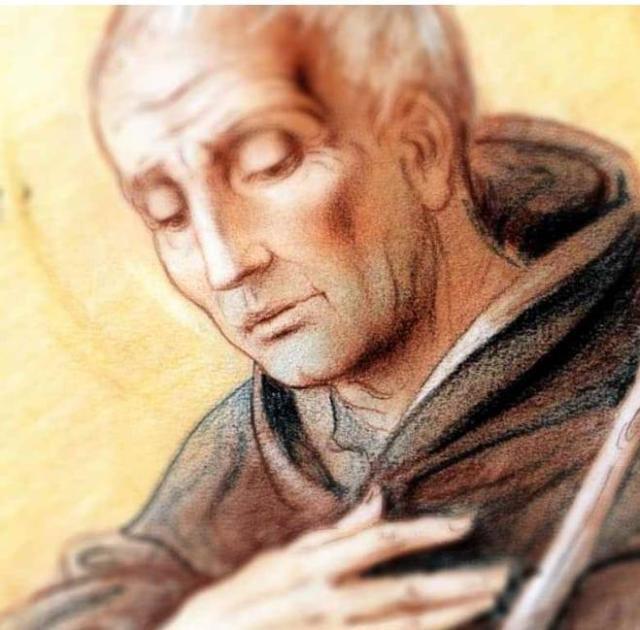Nell’ultima uscita de “Le parole dell’Europa” parleremo di democrazia. Un tema inevitabile a poche ore dal voto europeo e che potrebbe apparire scontato, ma che negli ultimi anni si è trovato al centro del dibattito. Recentemente, infatti, è emerso nell’est dell’Europa un fronte politico che ha spinto alcuni Paesi dell’UE verso modelli di “democrazia illiberale” che mettono in discussione valori fondanti della costruzione europea. Il tema tocca però anche i rapporti con i Paesi alle porte dell’Europa la cui transizione democratica, in diversi casi, sembra aver subìto una battuta d’arresto.
IL TEMA
L’Unione europea che si presenta all’appuntamento elettorale del 2019 non sembra in forma smagliante: sono passati pochi anni dalla fine della più grave crisi migratoria che ha colpito l’Europa dal secondo dopoguerra; molte economie europee sono ancora in lenta risalita dalla china della crisi finanziaria; sulla scena politica di molti Paesi membri, sono sempre più le voci critiche sul presente e sul futuro del progetto europeo. E’ in questo contesto che l’UE si interroga su quelle che sembrano sempre più due “grandi illusioni” dell’integrazione europea. La prima riguarda il ruolo dell’Unione europea nel mondo e, in particolar modo, alle proprie porte. La seconda è invece tutta interna all’UE e riguarda il contesto politico entro cui si stanno muovendo alcuni Stati membri. Le affronteremo a turno, mostrando come l’una sia in qualche modo il riflesso dell’altra.
Quella che si presenta crescentemente come un’illusione sul piano esterno riguarda il ruolo dell’UE quale attore capace di favorire pace, crescita economica e democrazia nel proprio vicinato e nel resto del mondo, non con la forza militare ma grazie all’attrattività del suo mercato unico e alla propria credibilità di garante del multilateralismo. L’idea che la leva economica e il soft power potessero bastare per “esportare” il modello europeo in aree sempre più instabili ai confini sud e est dell’UE è stata più volte messa a dura prova dai fatti (si veda “Le parole dell’Europa: Confini”). Tra l’instabilità seguita alle primavere arabe sulle sponde del Mediterraneo e i focolai ancora accesi nello spazio post-sovietico, quell’Unione europea che ha provato a circondarsi di un “anello di amici” si trova invece sempre più stretta in un arco di crisi. In questi contesti, potenze vecchie e nuove hanno contrapposto una “tradizionale” azione militare alla attrazione europea basata sul soft power. L’UE si è così trovata spiazzata, non riuscendo a esprimere un’azione comune ed efficace in politica estera e risultando del tutto impreparata sul piano militare – area in cui la collaborazione è ancora agli albori. Le promesse di pace e democrazia dell’Unione europea a diversi Paesi ai suoi confini orientali e meridionali sono quindi spesso rimaste lettera morta.
L’incapacità dell’UE di trovare unità di intenti nell’affrontare le sfide esterne è peraltro lo specchio delle sue divisioni interne. Proprio qui emerge quella che rischia di rivelarsi la seconda “grande illusione” europea: il teorema secondo cui l’appartenenza all’Unione europea avrebbe reso i suoi Paesi membri più simili tra loro sia sul piano economico, attraverso una progressiva convergenza, sia sul piano politico, attraverso la condivisione dei principi della democrazia liberale. D’altra parte era stata proprio questa visione ad ispirare l’intero processo di allargamento dell’Unione europea: dal Portogallo alla Spagna – appena usciti dall’esperienza dittatoriale – fino ai Paesi dell’Europa centro-orientale entrati nell’UE tra il 2004 e il 2007, la forza di attrazione di Bruxelles stava proprio nel garantire una transizione pacifica verso una piena democrazia, paragonabile a quella dei sei Paesi fondatori. Ciò si è tradotto nei cosiddetti “criteri di Copenaghen”, formalizzati dall’Unione europea nel 1993, che impongono l’adozione di istituzioni stabili e democratiche, rispetto dello stato di diritto, protezione delle minoranze, economia di mercato e impegno per un’integrazione politica, economica e monetaria sempre più profonda. L’aver legato i negoziati per l’accesso all’UE al rispetto dei criteri di Copenaghen ha in effetti funzionato per molti Paesi candidati, che hanno integrato porzioni significative del diritto europeo nel proprio ordinamento (il cosiddetto “acquis communautaire”) e implementato importanti riforme economiche e istituzionali con la prospettiva dell’adesione all’UE. La storia recente dell’integrazione europea, tuttavia, ha mostrato che i limiti di questa strategia si rivelano spesso non nel corso dei negoziati di adesione all’UE, ma piuttosto in un secondo momento, quando un Paese è già diventato Stato membro. Durante il periodo di pre-adesione, l’UE può infatti sospendere i negoziati con un Paese candidato se ritiene che i criteri di Copenaghen non vengano pienamente rispettati. Paradossalmente, invece, i meccanismi che permettono di controllare il rispetto degli standard democratici nei Paesi che sono già membri dell’UE sono molto più labili.

Nel grafico – La qualità della democrazia misurata in base al Freedom in the World 2019, Freedom House
Negli ultimi anni ad attirare l’attenzione di Bruxelles è stata in particolare l’Europa centro-orientale, dove alcuni Stati membri hanno mostrato i primi segni di un indebolimento della qualità della propria democrazia. In Polonia, Ungheria e, recentemente, in Romania, società civile e osservatori internazionali continuano a denunciare azioni di governo che – più o meno apertamente e più o meno efficacemente – interferiscono con l’opposizione politica, la libertà di stampa, l’indipendenza del sistema giudiziario e l’attività di organizzazioni non-governative. La risposta delle istituzioni europee è stata decisa e, da un certo punto di vista, inedita: per la prima volta nella storia dell’UE è stata infatti attivata la procedura dell’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea, che prevede la possibilità di sanzionare uno Stato membro che vìoli i “valori fondamentali” dell’UE, fino ad arrivare alla sospensione del diritto di voto in Consiglio. La Commissione europea ha attivato il processo per la prima volta nel dicembre 2017, contro la Polonia, dopo che il governo di Varsavia ha varato una riforma della giustizia che, secondo Bruxelles, metterebbe a rischio l’indipendenza dei giudici polacchi. La decisione è stata replicata poco tempo dopo, quando a settembre 2018 il Parlamento europeo ha votato per intervenire contro l’Ungheria, accusata di non rispettare i diritti dei migranti sul proprio territorio e di limitare la libertà di stampa. Nelle ultime settimane anche la Romania è finita sotto osservazione a seguito di una serie di azioni del governo che destano preoccupazione, in particolare in merito all’indipendenza del sistema giudiziario e alla separazione dei poteri.
La procedura dell’articolo 7 è considerata da molti “l’opzione nucleare” che le istituzioni di Bruxelles hanno a disposizione per vigilare sul rispetto della democrazia. Come accade spesso nelle procedure di governance europea, però, per arrivare alla fine del processo e dare concretezza alle minacce è richiesta l’approvazione del Consiglio europeo, in cui siedono proprio i rappresentanti degli Stati sotto accusa. E’ a questo punto che il meccanismo rischia seriamente di incepparsi: per avviare l’ultimo step giuridico prima delle sanzioni è infatti necessario un voto all’umanità da parte di tutti i Paesi salvo l’accusato, ed è probabile che il Paese sotto accusa trovi un alleato disposto a porre il veto, vanificando così l’intero procedimento. Sembra essere esattamente questa la situazione che si presenterà quando il Consiglio si troverà a discutere i casi di Polonia e Ungheria, i cui governi sono pronti a sostenersi a vicenda per evitare le sanzioni.
La situazione di Polonia, Ungheria e Romania rappresenta l’esempio più evidente dell’emergere di un fronte che unisce governi e forze politiche in vari Paesi europei sempre più attratti da modelli democratici “alternativi”. Modelli che, anche quando godono del sostegno popolare, rischiano però di risultare incompatibili con alcuni dei requisiti che l’UE considera fondamentali sin dalla sua fondazione: il rispetto per le minoranze e le diversità, i diritti umani, la separazione dei poteri. Significativamente, in nessuno di questi Paesi l’opinione pubblica è in maggioranza contraria all’appartenenza nell’Unione europea. Lo scontro tra Bruxelles e queste nuove “capitali illiberali” si gioca quindi non tanto sullo stare dentro o fuori dall’Unione europea, quanto piuttosto su quali debbano essere i valori che ne stanno alla base.
LE ANALISI
Marta Dassù: l’UE ha un problema di leadership?
L’UE non sempre è riuscita a prendere decisioni su alcuni dei temi più cari agli europei, con un danno di credibilità e legittimità che sarà faticoso riparare. All’Europa è mancato un leader che sapesse ricomporne le divisioni?
Guarda l’intervista

Articolo 7: troppo poco, troppo tardi, troppo politico?
Contro il rischio di un arretramento democratico in Polonia e Ungheria, l’UE è intervenuta attivando l’articolo 7. La scelta sarà sufficiente a riportare i due Paesi in linea con i requisiti stabiliti dai trattati europei? Leggi l’analisi
La dottrina Orbán
Il progetto del primo ministro ungherese Victor Orbán non è quello di un’uscita dall’Unione europea, ma di una sua rifondazione su criteri alternativi a quelli che hanno finora guidato l’integrazione europea. Leggi il commento
LA POSIZIONE DELL’ITALIA
Nonostante solo una minoranza di italiani (19%) sia apertamente contraria all’appartenenza all’UE e il 65% si dichiari a favore dell’euro, stando ai dati Eurobarometro gli italiani sono tra i cittadini europei meno “euro-entusiasti”. Solo poco più di un italiano su tre crede che far parte dell’Unione europea sia una cosa positiva, solo quattro su dieci pensano che il Paese ne abbia beneficiato e appena il 36% ha fiducia nelle istituzioni comunitarie. L’”euroscetticismo” italiano va però contestualizzato in quello che appare come un clima di generale sfiducia verso le istituzioni democratiche: se solo un italiano su quattro crede che la propria voce conti in Europa, sono comunque meno della metà a pensare che essa conti in Italia (40%).
Il fatto che in uno Stato fondatore, tra i più grandi dell’Unione europea, soltanto un terzo dei cittadini creda che il proprio Paese influenzi le decisioni prese dall’UE è indicativo di una percezione diffusa, che non sempre è però giustificata dai fatti. In primis, infatti, bisogna considerare che il Parlamento europeo – eletto direttamente dai cittadini – è ormai da tempo determinante nella maggior parte delle decisioni prese a livello europeo. Inoltre, molti italiani si sono trovati a ricoprire negli ultimi anni posizioni chiave all’interno dell’UE: da Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani; dall’Alto rappresentante dell’UE per la politica estera, Federica Mogherini, ai quattro direttori generali della Commissione europea Raffaele Petriccione, Roberto Viola, Marco Buti e Stefano Manservisi. Dal Trattato di Lisbona del 2009 in poi, nessun altro Paese europeo – Francia e Germania inclusi – si è trovato a rappresentare contemporaneamente così tante cariche apicali. All’interno dello staff della Commissione europea, gli italiani rappresentano poi il secondo gruppo più numeroso (12% del totale), dopo i belgi, con quasi 4.000 dipendenti.
Se pure è difficile che una situazione così favorevole all’Italia si ripresenti nel prossimo futuro, è anche vero che non basta “riempire le caselle” del personale dei palazzi di Bruxelles per far sentire la propria voce.
La percezione che la voce degli italiani conti poco in Europa, infatti, è forse anche dovuta al modo in cui sono state gestite – tanto dal lato italiano quanto da quello delle istituzioni europee – politiche e temi chiave per l’Italia, come ad esempio la gestione del bilancio pubblico e la risposta poco solidale alla crisi migratoria. Un senso di inefficacia dell’azione a livello europeo che accresce la percezione degli italiani di un “deficit democratico” dell’Unione. Un deficit che va colmato rendendo più efficace l’azione italiana a Bruxelles e aumentando la capacità di azione dell’Unione europea proprio sui temi per i quali i cittadini, italiani e non, avvertono l’esigenza di una più forte risposta comunitaria.