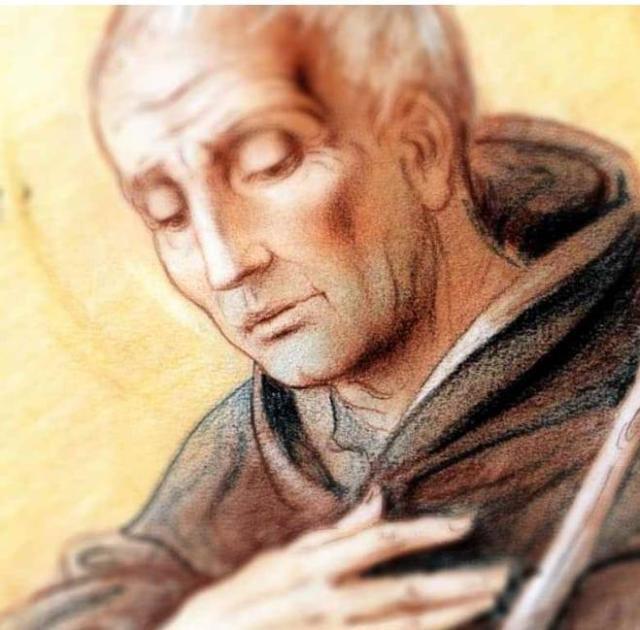Gli attentati a Kabul hanno smontato definitivamente ogni possibile narrazione vittoriosa. Per Biden reggere altri tre anni e mezzo di presidenza in queste condizioni sarà molto complicato. E all’orizzonte non c’è solo l’Afghanistan, è in discussione l’intera agenda e i dem si sono spaccati.
La strage annunciata. La ritirata di Kabul ha un finale scandito dalla morte, siamo di fronte a uno dei giorni più neri della storia americana, il tramonto in culla di una presidenza, quella di Joe Biden, che è già segnata.
Il nostro dovere è quello di raccontare i fatti, esporli per quello che sono e non per quello che si desidera, l’impaginato è sotto gli occhi di tutti: un ritiro precipitoso, sbagliato nei tempi (sotto la stagione dei combattimenti), nei modi (senza un’adeguata copertura militare e logistica per l’evacuazione) e privo di una reale tessitura politica (con un accordo di non belligeranza, almeno in questa fase, di tutti i clan sul terreno).
I gruppi estremisti presenti in Afghanistan hanno colpito, Isis e Al Qaeda sono entità reali e letali, quello che si chiama “clear and present danger”. Tutti erano informati, avvisati, c’erano fonti aperte chiare e rapporti riservati chiarissimi, ma Biden ha tirato dritto, ha preso una decisione facendosi dettare l’agenda prima da ragioni di politica interna (cercare di capitalizzare il ritiro nel voto di midterm del 2022) e poi, di fronte al crollo delle istituzioni afghane, dalla paura, così ha premuto sull’acceleratore del ritiro, una vera e propria fuga, facendosi dettare i tempi dai Talebani (“entro il 31 agosto o ci saranno conseguenze”).
Così si sono create addirittura le condizioni ideali per un attentato: il caos all’aeroporto, gli ingressi dello scalo trasformati in calca, con una pressione esterna incontrollabile, nessuna possibilità di regolare il flusso della massa di persone disperate. Era solo una questione di tempo. Un’occasione unica per chi ha in mente il caos e vuole tenere aperta la “lunga guerra” trasformandola in una guerra civile. La sintesi l’ha fatta qualche giorno fa l’Economist con una copertina che è una sentenza definitiva: “La debacle di Biden”.
Il quadro politico, che era già grave dopo ben quattro discorsi di Biden – che non avevano convinto neppure le corazzate dei media liberal – ora è un paesaggio di macerie fumanti sia sul piano interno che su quello dei rapporti internazionali. Andiamo con ordine, cominciamo dallo scenario americano.
Biden ha ragionato pensando agli elettori americani, di fronte a un partito repubblicano “trumpizzato”, il Presidente ha giocato la mossa del ritiro (una carta dell’amministrazione Trump che aveva negoziato a Doha gli accordi con i Talebani) da far coincidere con le celebrazioni dell’11 settembre (ricordiamo che la data originaria era quella, poi anticipata perché qualcuno aveva fatto notare alla Casa Bianca che si trattava di un boomerang della comunicazione) per dire agli americani che “i nostri ragazzi sono tornati a casa“, Osama Bin Laden (sul quale torneremo tra qualche riga, perché la tragedia s’accompagna alla beffa) è stato eliminato, il nemico è sconfitto, la guerra è finita, il classico “Victory Day” con l’inno e la bandiera.
Poteva funzionare fino a qualche ora fa, perfino con un ritiro così disordinato, ma l’attentato ha smontato definitivamente ogni possibile narrazione vittoriosa, il racconto del grande ponte aereo americano su Kabul è esploso con i kamikaze dell’Isis. I democratici sono frastornati, l’Afghanistan – di cui gli americani si sarebbero (forse) dimenticati in fretta – resterà fissato nella memoria perché il bilancio degli attentati è pesante (siamo a 72 morti e attenzione, sono caduti dodici Marines), il presidente ne esce con lo stigma del “Commander in Chief” inadeguato.
Questo quadro proiettato sul voto di midterm, in caso di riconquista del Congresso da parte dei repubblicani, porterà all’apertura di una stagione di battaglia parlamentare speculare a quella che i Democratici fecero durante la presidenza Trump, dunque apertura di una commissione d’inchiesta, accertamento delle condizioni fisiche e mentali del presidente (invocando il 25esimo emendamento della Costituzione americana) e infine procedura di impeachment di Biden che, ricordiamolo, è in carica da soli sette mesi.
Reggere altri tre anni e mezzo di presidenza in queste condizioni sarà molto complicato. E all’orizzonte non c’è solo l’Afghanistan, è in discussione l’intera agenda Biden e i dem si sono spaccati.
Sul piano internazionale in soli sette mesi è riuscito a incrinare l’autorevolezza della sua presidenza di fronte agli alleati. È vero che i leader europei lo preferiscono a Trump, ma il presidente che doveva riavvicinare le due sponde dell’Atlantico in realtà le ha allontanate, dando un colpo quasi mortale alla credibilità della Nato (quale Parlamento voterà in futuro le missioni militari senza un aspro dibattito interno, l’opinione pubblica smarrita e maggioranze in aula incerte?), mettendo in crisi il rapporto con gli alleati che sconsigliavano il ritiro dall’Afghanistan in estate e avevano timori (negati da Biden e rivelatisi poi fondati) di un collasso dell’esercito afghano, privo di sostegno politico e morale di fronte all’avanzata dei Talebani che andava avanti da settimane.
Il risultato del G7 è sotto gli occhi di tutti, lo sguardo di Ursula di von der Leyen era un dipinto d’amarezza. Oggi Biden ha un bisogno disperato degli alleati europei, ma la sua agenda di politica estera è diventata improvvisamente un problema di format dei forum di cooperazione. Vanno ripensati, perché l’Atlantismo non può essere in discussione, ma gli americani non possono decidere nella maniera che abbiamo visto quando si va a bordo e quando si scende dall’auto in corsa. Qualcuno si fa male. È accaduto.
L’Afghanistan è diventato uno spartiacque geopolitico, un fatto che avrà effetti a lungo termine, mette in moto antiche e nuove forze, offre uno spazio alla Cina (che riempirà il vuoto aperto dagli Stati Uniti), incoraggia i nemici di Israele, suggerisce all’Iran che in fondo la bomba atomica si può fare, riapre il Grande Gioco in Asia Centrale e ha effetti a lunga gittata, conseguenze inattese che scopriremo presto.
Tutto parte dalla storia dello sceicco del terrore, Osama Bin Laden. E alla tragedia oggi s’accompagna la cinica beffa. Zabihullah Mujahid è il portavoce dei Talebani, non ne avevamo mai visto la sagoma fino a quando in Afghanistan non è riapparsa la bandiera bianca degli islamisti e con la capitale è caduta anche la maschera dello “speaker” talebano. Fin dal primo giorno il signor Zabihullah è apparso con lo sguardo della vittoria che gli fiammeggia nelle pupille. Egli non parla, detta; non spiega, sentenzia; non risponde, decreta; non dialoga, oracoleggia. Lo illumina il bagliore divino della Verità Talebana e ieri ne abbiamo avuto un saggio: secondo Zabihullah “non c’è alcuna prova” del coinvolgimento di Osama Bin Laden negli attentati dell’11 settembre 2001 e dunque “non c’era nessuna giustificazione per questa guerra. Si trattò solo di una scusa”. Tra i tanti effetti della caduta di Kabul dunque c’è anche la riscrittura della storia.
Osama Bin Laden fu la mente e il braccio del 9/11, Al Qaeda aveva già colpito duramente gli Stati Uniti, una lunga scia di sangue, il primo tentativo di far crollare le Torri Gemelle si consumò il 26 febbraio del 1993, un furgone carico di esplosivo, l’architetto del primo colpo fu Ramzi Yousef, guarda caso nipote di Khaled Sheikh Mohammed, l’uomo che ideò il piano d’attacco dell’11 settembre 2001. Tutti i pezzi sulla scacchiera si muovono intorno a Osama Bin Laden e ai suoi contatti. Fu Sheik Mohammed durante un incontro a Tora Bora a parlare a Bin Laden per la prima volta del suo piano per colpire le Torri Gemelle, “modificato” con l’uso degli aerei di linea come dei missili teleguidati.
Lo sceicco del terrore lo perfezionò, reclutò il gruppo di kamikaze, organizzò attraverso la rete di Al Qaeda la logistica e il finanziamento di un’operazione su scala globale. Questo fil rouge è documentato nel report della commissione d’indagine parlamentare dell’11 settembre 2001, ricostruito nel dettaglio in una serie di libri pubblicati in questi anni, inchieste fondamentali per capire l’evoluzione del terrorismo islamista, la nascita di Al Qaeda e il ruolo chiave di Bin Laden. I Talebani con un colpo di spugna hanno cancellato anche questo, Zabihullah riscrive la storia. Troppo.
L’esercizio del potere del “Commander in Chief” da parte di Biden ora è in discussione. Ci sono molti esempi a cui ispirarsi, il migliore resta quello di Winston Churchill che rispedì al mittente i tentativi di Chamberlain e Halifax di consegnare la resa dell’Inghilterra a Hitler. “Volete che la svastica sventoli su Windsor?” No! Risposero a Westminster. È a quel punto che Churchill trova le parole che mandano in battaglia l’Inghilterra contro Hitler, con il cuore e con la mente, il potente e magnifico discorso che consegna alla storia la sua figura, l’oratore e lo stratega, il politico e il soldato, l’uomo che metterà le ali alla vittoria nella Seconda guerra mondiale.
Biden non è Churchill, l’Afghanistan non è Dunkerque, ma qui stiamo parlando di una cosa chiamata “carattere”, il senso della leadership. Per questo il ritiro americano appare un’immane tragedia destinata a far sentire i suoi effetti nella dimensione della “longue durée”, il tempo lungo della storia.
Churchill ricordò a Re Giorgio VI, in un drammatico colloquio privato in cui decisero di non cedere a Hitler, che una nazione che si arrende senza combattere, declina. Così oggi una nazione che si ritira, può subire l’attacco vigliacco dei terroristi nel momento più delicato e pericoloso, quando ripiega. È successo.
Tutti i presidenti americani volevano uscire dall’Afghanistan (e soprattutto il primo, George W. Bush, non avrebbe mai voluto entrarci), la guerra è brutta, sporca, cattiva. Tutti i presidenti americani pensavano di colpire e poi lasciare il Paese in un tempo per loro ragionevole.
George W. Bush non aveva alcuna intenzione di impegnarsi con la guerra, la sua politica estera si preparava a entrare nei canoni di una quieta gestione di tradizione repubblicana, i democratici lo avevano già catalogato alla voce “isolazionista”, i media in progress gli avevano cucito addosso il vestito del texano tutto ranch e grill. E aveva affidato alle mani esperte di Dick Cheney la pratica del mestiere delle armi. La mattina dell’11 settembre 2011 quel racconto cambiò: quattro aerei dirottati, giù le Torri Gemelle nel cuore di Manhattan, il muro del Pentagono, l’edificio più sicuro e più grande degli Stati Uniti, sfondato da un aereo di linea, un altro volo precipitato nelle campagne di Shanksville. L’America era sotto attacco. L’America era in guerra. Eravamo tutti americani. Questa storia viene dimenticata regolarmente da quelli che dicono la sciocchezza più grande: la democrazia non si esporta. È vero il contrario, si esporta e cresce, ma serve il tempo e lo spirito di sacrificio che l’Occidente non ha più.
Dopo mesi di battaglia apparve chiaro che era impossibile perfino controllare Kabul senza rischiare di saltare in aria su una “roadside bomb”, mentre nel resto del territorio, nelle province, gli americani si muovevano al buio, sotto il tiro dei cecchini. Bush fece i suoi due mandati, ma l’Afghanistan rimase un buco nero strategico.
Quando Obama arrivò, il suo pensiero era quello di ritirarsi, l’emergenza di Barack era il collasso economico-finanziario americano, la crisi del 2007-2008, i fallimenti delle banche e il crac dell’industria dell’automobile. Obama voleva uscire dall’Iraq, ma al Pentagono gli dissero che non era ancora possibile. Lui, il premio Nobel per la pace, aggiunse alla killing machine americana una flotta di droni e insieme alla “killing machine” del Pentagono crebbe anche la “killing list” del presidente, la guerra silenziosa.
Due mandati di Obama non risolsero il problema, ma il presidente nel 2011 mise a segno il colpo con la pallottola d’argento, l’eliminazione in Pakistan di Osama Bin Laden (e nella foto che fissò nella storia quel momento c’era anche lui, Joe Biden). Quello poteva essere il “carpe diem”, l’istante da cogliere per andare via, salutare tutti e dire che la missione è compiuta. Obama decise di rimanere a Kabul, si illuse di vincere senza combattere con i “boots on the ground”.
Ma quell’operazione riuscì solo una volta nella storia americana, a Harry S. Truman, che si assunse sulle spalle la gigantesca responsabilità di sganciare due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Resa dei giapponesi e chiusura del fronte nel Pacifico. Obama fu avviluppato dalla guerra in Siria, finanziò gruppi ribelli pensando di far cadere Assad, senza vedere che i guerriglieri che foraggiava non erano dei sinceri democratici ma dei macellai al pari del regnante siriano. Da cotanto ingegno strategico della Casa Bianca nacquero le bande nere l’Isis che in poco tempo sfondarono le linee in Iraq, aprendo un conflitto regionale, una banda di criminali psicopatici tenne in scacco la più grande potenza del mondo. E ci risiamo, in Afghanistan.
Donald Trump, ebbe l’originale idea che accarezzavano tutti gli altri: ritirarsi. Fece piani, contropiani, dichiarazioni, insomma… Trump. Sparò un paio di missili polverizzando il covo di Abu Bakr Al Baghdadi ed ebbe il suo momento da cacciatore di taglie. I generali gli spiegarono che ritirarsi non era un buon affare, lui lasciò fare al Pentagono, perse le elezioni e lasciò il caso aperto a un altro presidente. Joe Biden l’ha chiuso. E vent’anni dopo ha riaperto il cancello di un mondo in fiamme. Ha ragione il segretario di Stato Antony Blinken, Kabul non è Saigon, è peggio. Good Morning, Afghanistan.
AGI