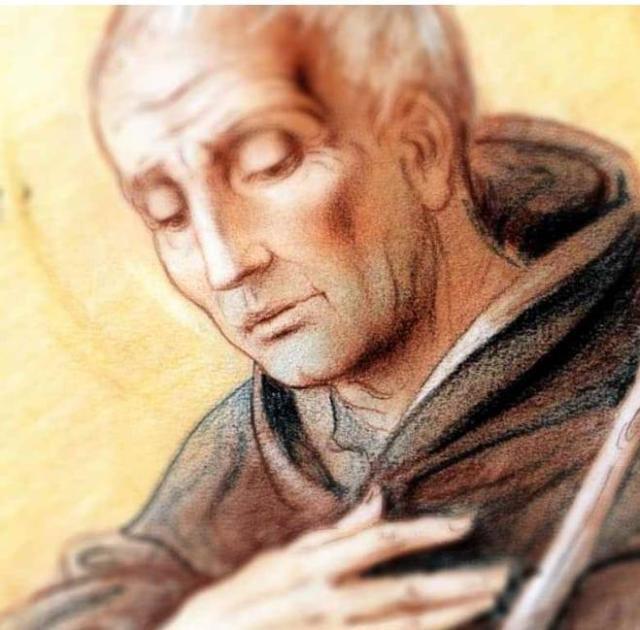Santa Cecilia, profumo di Natale a Taranto
di Evelyn Zappimbulso
Frutto, verosimilmente, di un errore in cucina, le pettole di Santa Cecilia sono il simbolo della gastronomia tarantina sebbene siano presenti sulle tavole di gran parte del sud Italia dove vengono chiamate anche cuculi, pasta crisciut, popizze, rospitelli, scrpedd e sfingi.
Sono buone al naturale e risultano apprezzabili sia nella versione dolce che salata, eventualmente arricchita all’interno con pesce, salumi o formaggi.
Periodo di preparazione delle pettole
Secondo la tradizione, le pettole compaiono nei menù tarantini il 22 novembre, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Cecilia, protettrice dei “musici”, data che a Taranto segna anche l’inizio dell’Avvento e i preparativi del Natale.
Altrove si è soliti prepararle anche l’11 novembre, per la festa di San Martino, e per l’Immacolata dell’8 dicembre tanto che, in Salento, un antico proverbio recita: «Ti la Mmaculata la prima ffrizzulata, ti la Cannilora l’ultima frizzola», ovvero «Nel giorno dell’Immacolata, la prima preparazione di pettole, nel giorno della Candelora, l’ultima».
Più in generale è possibile gustare le pettole durante tutto il periodo natalizio, quando familiari ed amici si riuniscono intorno alla tavola imbandita per i festeggiamenti.
Storia delle Pettole di Santa Cecilia
Si ritiene che il nome “pettola” provenga dalla parola latina “pitta”, che significa “focaccia”, sebbene sia possibile rintracciare l’origine etimologica della parola nella leggenda relativa alla loro nascita la quale è giunta fino a noi in ben tre versioni.
Tre versioni dell’origine di una ricetta nata per caso
La prima narra di una donna tarantina che il giorno di Santa Cecilia, dopo aver preparato l’impasto per il pane, lo lasciò lievitare troppo a lungo perché distratta dalla musica dei pastori transumanti abruzzesi che, in quel periodo dell’anno, erano soliti spostarsi regalando la dolce melodia delle loro zampogne in cambio di cibo. Catturata dall’armonia di quelle note, la donna si era allontanata da casa per seguire i musicanti per le vie di Taranto e, solo dopo avervi fatto ritorno, poté rendersi conto che l’impasto oramai mal si sarebbe prestato per la successiva panificazione. Non volendolo sprecare, lo ridusse in palline che, una volta tuffate nell’olio bollente, si gonfiarono e dorarono.
Nell’offrirle ai figli questi, dopo averne apprezzato la bontà, ne chiesero il nome; «pettel» rispose la donna, ossia piccola focaccia, poiché sembravano proprio somigliare alla focaccia che in dialetto locale è detta “pitta”. Non completamente soddisfatti, domandarono ancora «E ‘cce sont?» (cosa sono?) e lei, notando che erano morbidi e soffici rispose «I cuscin’ du Bambinell» (i guanciali di Gesù Bambino).
Una volta terminato di friggere le pettole, scese per la strada per offrirle anche agli zampognari che avevano reso possibile l’invenzione di questa gustosa ricetta.
Una seconda versione della stessa leggenda, narra che fu San Francesco d’Assisi a distrarre volontariamente dalla finestra la donna mentre passava nei pressi della sua casa. Un’altra ancora riferisce, invece, che la donna fosse in realtà intenta a parlare con una vicina e non si accorse, se non in ritardo, che l’impasto aveva lievitato troppo.
Al di là delle leggende, riteniamo che il popolo minuto, che nel passato, disponeva di poche risorse, nello specifico semplice acqua e farina, fosse solito festeggiare il periodo natalizio con le frittelle, un piatto considerato ricco e impegnativo, se pensiamo al costo che anticamente doveva avere l’olio.

Tradizione e origini “povere” di una tipicità del Sud Italia
Tradizionalmente, la notte del 22 novembre, le donne, dopo essersi procurate “’u luat”, e cioè un pezzetto di pasta cresciuta da usare come lievito, che nel passato era consuetudine scambiarsi tra vicine, si alzavano intorno alle due per impastare (“trumbà”) una quantità considerevole di farina, all’interno di un grande recipiente in terracotta, smaltato, “u’ limm”. Le pettole avrebbero costituito il pranzo e la cena per sfamare le numerose famiglie, fattore questo che giustificherebbe il grande quantitativo di farina impiegato.
L’impasto veniva messo a lievitare in un luogo caldo, lontano da spifferi e correnti d’aria che potessero interferire con il processo di fermentazione e, a questo scopo, si era soliti proteggerlo con una coperta di lana, la “manta di lana”, avendo cura di lasciarlo riposare accanto alla cucina a legna (“a fracassà”), ma molto più frequentemente accanto al camino.
Una volta terminata la lievitazione si poteva procedere alla divisione dell’impasto in piccoli bocconcini o ciambelle che successivamente sarebbero state fritte.
Oggi tutte le fasi di preparazione delle pettole sono semplificate ma gli ingredienti sono rimasti gli stessi: farina, lievito, sale, acqua e olio per friggere.
I loukoumàdes, bocconcipi ellenici simili alle pettole
Nella tradizione culinaria ellenica troviamo una ricetta molto somigliante nella forma, e in parte nella sostanza, alla pettole salentine: i “loukoumàdes”, piccoli bocconcini di pasta lievitata e fritta, imbevuti nel miele.
Si ritiene, tuttavia, che la loro provenienza sia turca e non italica. Probabilmente, furono introdotti durante il periodo della dominazione Ottomana, storicamente di molto posteriore all’età dell’oro della Magna Grecia.
L’odore delle pettole il giorno di Santa Cecilia (22 novembre) riempie le vie di Taranto ancora assonnata. Come da tradizione, si frigge alle cinque del mattino in tutte le case. Si consuma la colazione con pettole calde, latte e caffè e poi, tutti odoranti di Natale si inizia la giornata lavorativa con la gioia nel cuore che ogni attesa di rinascita e speranza porta con sé.
Redazione Corriere di Puglia e Lucania