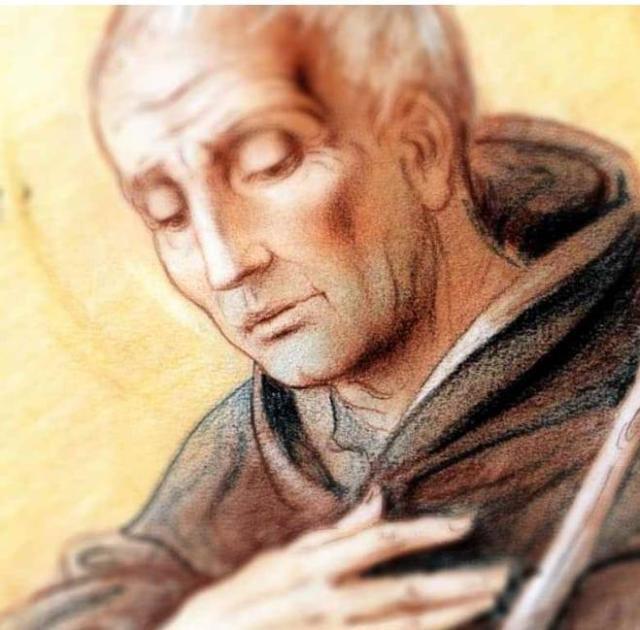Dante e Beatrice
«Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua deven tremando muta
e gli occhi no l’ardiscon di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d’umiltà vestuta;
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terra a miracol mostrare.
Mostrasi sì piacente a chi la mira,
che dà per gli occhi una dolcezza al core,
che ’ntender no la può chi no la prova:
e par che da la sua labbia si mova
un spirito soave pien d’amore,
che va dicendo a l’anima: Sospira.»
(D. Alighieri, Vita nova, XXVI)
di Giuseppe Lalli
Sono, questi, versi assai celebri che molti di noi hanno appreso a scuola e che Dante Alighieri (Firenze 1265 – Ravenna 1321), poeta tra i più grandi di tutti i tempi di cui si sono appena celebrati i settecento anni dalla morte, dedica a Beatrice Portinari nella Vita nova, opera scritta presumibilmente dal grande poeta fiorentino tra il 1292 e il 1295. Una melodia ineffabile, più divina che umana, si leva da queste strofe.
Qualunque poeta, che, in ogni tempo, sia stato innamorato di una donna, trova in esse l’espressione più sublime del suo sentimento.
Il Romanticismo dell’Ottocento ha in questi versi il suo vero atto di nascita. Già, perché il romanticismo non è solo un movimento letterario che fiorisce in Europa alla fine del Settecento, ma uno stato dell’anima, una “categoria dello spirito”.
Nella letteratura come nell’arte, in generale, vale il principio biologico “Nulla si crea nulla si distrugge: tutto si trasforma”.
C’è da credere che senza l’amore cantato dai trovatori provenzali, dai poeti siciliani, dagli stilnovisti e poi da Francesco Petrarca (1304-1374), non avremmo avuto né le liriche di Ugo Foscolo (1778-1827) né i canti di Giacomo Leopardi (1798 -1837).
Che Dante fosse uno spirito romantico e passionale non v’è dubbio alcuno. Per convincersene, basti riandare con la memoria al celeberrimo canto V dell’Inferno, quello in cui si parla dell’amore infelice tra Paolo Malatesta e Francesca da Polenta. Di fronte al loro dramma (i due cognati, che avevano intrecciato un’intensa relazione sentimentale, vengono scoperti e uccisi dal marito di lei) Dante si commuove a tal punto che alla fine del racconto che della loro tragica storia fa Francesca con accenti accorati, non può evitare di perdere i sensi e cadere «come corpo morto, cade» (Inf., V, 142). La stessa condanna che loro infligge (travolti incessantemente da un vento tempestoso) prevede che siano destinati a non essere mai separati, ciò che di certo raddolcisce la loro condizione penosa.
La Vita nova, una raccolta di versi e di prose che si alternano armoniosamente su di una trama tenue, è la storia di un intenso amore “platonico”, è l’esaltazione lirica, a tratti mistica, di un sentimento che accompagnerà il poeta lungo tutto il percorso della sua avventurosa vita terrena.
Ma è una storia reale, un’autobiografia dei sentimenti, un diario del cuore che ben potrebbe intitolarsi Il poeta e la donna amata. L’immaginazione idealizzante vi gioca un ruolo importante ma del tutto accessorio: una misura di stile che il poeta conferisce ad uno slancio che è umano e carnale.
Tutto ha inizio da un incontro nel sesto di Porta San Piero, lo stesso dove Dante è nato e vive. Beatrice, detta Bice, è figlia di Folco Portinari, un ricco mercante vicino di casa degli Alighieri.
La bambina ha da poco compiuto gli otto anni, Dante sta per compierne nove. Lei è già matura e molto graziosa.
Il poeta così la descrive: «vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata a la guisa che a la giovanissima etate si convenia» (Vn, II, 7-8).
Il giovane rampollo degli Alighieri se ne innamora perdutamente: «D’allora innanzi dico che Amore signoreggiò la mia anima» (Vn, II, 18). Ma è solo amore d’immaginazione, naturalmente, sospiri di un adolescente: «l’angiola giovanissima», cercata affannosamente, non si accorge di lui. Dovranno passare nove anni (nove, multiplo di tre, numero perfetto, è simbolo ricorrente nella trama poetica dell’Alighieri) perché il miracolo avvenga. La incontra di nuovo, lui diciottenne, lei giovane e bellissima dama in compagnia di due più attempate signore. Questa volta è vestita di bianco, il colore degli angeli. Il giovane Dante trema dall’emozione, cerca di farsi notare ed…ecco che Beatrice incrocia il suo sguardo e…lo saluta molto cordialmente.
Uno sguardo e un saluto, niente di più, ma tanto può bastare a schiudere al cuore di un poeta le porte del Paradiso. Allorché la vedrà apparire, alla sola speranza di ricevere il suo saluto, Dante si sente raggiunto da una fiammata di carità che lo dispone a tutto perdonare a chi l’ha offeso, disponendolo all’amore e all’umiltà.
Ma non dobbiamo farci ingannare dalle parole: dietro simboli e immagini spirituali c’è pur sempre una donna in carne ed ossa, e dietro gli slanci mistici c’è il turbamento dei sensi. Per rimirarla, va ad appostarsi nell’unico posto dove in quel tempo un giovane può contemplare la sua bella: in chiesa, dove Bice canta le lodi alla Madonna con voce celestiale, e dove gli sguardi sensuali possono mimetizzarsi di sacro.
E che importa se l’incantevole ragazza è sposata ad un facoltoso signore di nome Simone de’ Bardi: i matrimoni, al tempo, si combinano fin dalla culla, poco hanno a che fare con la passione.
In chiesa, al giovane innamorato viene in aiuto la geometria spaziale: tra Dante e Bice si frappone casualmente una donna giovane e assai piacente, che presto crederà di essere lei la destinataria degli sguardi ardenti del poeta, il quale sta volentieri al gioco, che durerà per molto tempo.
L’ignara e compiaciuta fanciulla, che Dante chiamerà «donna dello schermo», serve al poeta a celare il suo vero sentimento, ed impedire così che il nome soave di colei che ama possa essere profanato dal pettegolezzo.
Basti un episodio a dare la misura della sua passione. Un giorno, invitato da un amico, Dante si reca in una casa dove si festeggia un matrimonio.
Tra le dame che fanno da corona alla novella sposa egli riconosce Beatrice. Il suo viso comincia a tradire un’emozione così forte che l’amico, sottraendolo alla derisione delle donne che si sono accorte del suo pietoso stato d’animo, lo trascina via (chi non ha conosciuto, almeno una volta nella vita, questi tremori?).
Ma non passa molto tempo e un terribile presagio di morte si affaccia nella mente del giovane poeta.
A Beatrice verranno a mancare dapprima un’amica e poi l’amatissimo padre; poi sarà lei a cadere sotto la falce della donna vestita di nero.
A soli ventiquattro anni, il Cielo, sua vera patria, la reclama.Il cuore di Dante prende a sanguinare: non si dà pace, non si rassegna alla sciagura, tutte le fibre dell’anima ne sono scosse.
D’ora in poi il nome di Beatrice sarà scritto nei suoi pensieri e nei suoi sospiri. Per Beatrice Dante si fa persino pittore e in un passo del suo poetico romanzetto scrive che, riandando con la mente alla sua immagine nel primo anniversario della sua morte, disegnava «uno angelo sopra certe tavolette» (Vn, XXXIV, 2).La morte della donna amata lo ha letteralmente prostrato, condotto ai limiti della disperazione. Non basta a consolarlo la lettura dei classici latini, né la passione politica, che coltiva quasi al pari della poesia, basta a dare un senso pieno alla sua vita. Le ferite del cuore sono dure da rimarginare. Impiegherà anni per uscire dalla sua desolazione, fino a quando non decide di «dire di lei quello che mai non fue detto d’alcuna» (Vn, XLII, 2).
Senza questa cronaca sublime di un amore per una donna reale non ci sarebbe mai stata quella Commedia che Giovanni Boccaccio (1313-1375), molti anni dopo, chiamerà «Divina», o non ci sarebbe stata nel modo in cui è stata concepita e realizzata: un’opera in cui l’umano e il divino si intrecciano ad ogni piè sospinto.
Ma nella Vita nova, Beatrice, per quanto angelicata, in omaggio ai canoni estetici del Dolce stil novo, non è ancora allegoria della fede salvifica e guida nel viaggio verso la patria celeste.
Dante deve passare attraverso la rassicurante presenza di un’altra «donna gentile», un’ancella che non susciti la gelosia della sua Bice.
Questa donna matura che sul finire della Vita nova si offre di servirlo senza nulla chiedere in cambio incarna la Filosofia.
Ed ecco allora il poeta impegnarsi per trenta mesi ad acquisire quegli strumenti intellettuali che saranno poi fissati nel Convivio, altissima opera di pensiero, ma incompiuta, perché non tutto può spiegare l’umana ragione.
Ritorna quindi la poesia dove la filosofia non può arrivare: la ragione deve cedere il passo al cuore e «la donna gentile» ridar la scena alla donna amata. Ma nulla del nuovo e sudato sapere viene abbandonato: tutto viene trasfigurato. Accade sempre così: quando mente e cuore si mettono d’accordo niente può arrestare la bellezza, che è parente stretta della verità.
Ci sono momenti nella vita di un uomo in cui si giunge ad un bivio: si deve scegliere se dominare la vita o lasciarsi dominare da essa, obbedire alla vocazione per cui si è nati o seguire la corrente della comodità: occorre dare una disciplina al cuore.
Per Dante questo momento viene il Venerdì Santo del 1300, anno del grande Giubileo indetto da Bonifacio VIII (1230-1303), presumibilmente ai primi di aprile.
Accade allora che il poeta, piuttosto che lasciarsi schiacciare dal peso di una tristezza infinita, piuttosto che recriminare contro quel Dio che gli ha portato via la donna amata, stringe il cuore tra le mani, e decide di lottare: prende Dio per il bavero, lo sfida a duello, e concepisce nella sua mente rischiarata dalla grazia di porre mano ad un’opera che sarebbe stata al tempo stesso una sfida accettata e una promessa mantenuta. Sicuramente avrà risuonato a lungo nella sua anima il grido di Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore.
Le alterne vicende di quella lotta politica nella quale generosamente si è tuffato nella sua Firenze lo porteranno fuori della sua patria, in un esilio che sarà al tempo stesso triste e fecondo. L’immagine di Beatrice lo accompagnerà per tutta la vita. Essa, ancora viva, se la sarà figurata guardarlo quando egli, giovane cavaliere dell’esercito fiorentino, dopo le gloriose giornate di Campaldino, partecipava alle giostre sotto le assediate mura di Arezzo. E adesso è lì, davanti ai suoi occhi, stagliata sul suo orizzonte esistenziale, a sostenerlo, insieme alla sua incrollabile fede cristiana, nelle innumerevoli e spesso umilianti vicissitudini del suo esilio.
Sta lì, davanti ai suoi occhi, quando rifiuta con sdegno, lui che pure ama molto la patria fiorentina, di accettare, in cambio del rientro concessogli, di acconsentire alla condizione di chiedere perdono nel battistero di S. Giovanni con un rito pubblico, ciò che equivarrebbero a riconoscere una colpa che sa di non avere; anzi si aspetta che i suoi concittadini gli riconoscano semmai i suoi meriti di poeta, come scrive all’inizio del canto XXV del Paradiso: «ritornerò poeta, e in sul fonte / del mio battesmo prenderò ’l cappello».
E sta vicino a lui, la sua donna, soprattutto quando, ogni giorno, riprende a scrivere quel poema a cui ha posto mano «e cielo e terra»: Dio e la sua Beatrice.

È legge immutabile del cuore umano, già rintracciabile nei poemi di Omero, che l’uomo che ama cerca in ogni sua azione di piacere, anche solo idealmente, a chi è oggetto del suo amore, e tanto gli basta (quante infedeltà non commettiamo solo perché si perderebbe la stima e la fiducia dei figli, che amiamo, e che ci vediamo comparire davanti ai nostri occhi?).
Per quel poco che si conosce della sua vita privata e per quel tanto che si ricava dalle sue opere, Dante ci appare uomo dal carattere forte, orgoglioso, non accomodante nemmeno con sé stesso, disposto al sacrificio per affermare ciò in cui crede, e con una grande consapevolezza della sua intima vocazione.
Al contrario di Petrarca, Dante non si lecca le ferite. Ciò che in Petrarca è ostentazione di fragilità in Dante è occasione di esercizio di fortezza; ciò che in Petrarca è paralizzante malinconia, in Dante è energia vitale; ciò che in Petrarca è rifugio intimistico, in Dante è apertura al mondo. Petrarca intinge la sua penna nelle lacrime, Dante nella carne e nel sangue. Dante non è un rassegnato, è un combattente, anche nel senso stretto della parola: non gli basta saper usare la penna, al bisogno non disdegna di impugnare la spada. Si rammarica di trovarsi, a causa della miseria in cui è caduto, «equis armisque vacantem» (Ep.II, 8), senza cavalli e senza armi. Non ama la guerra, ma non si rifiuta di servire in armi la sua città, vale a dire la sua patria. A soli ventiquattro anni ha preso parte alla battaglia di Campaldino, tra i cavalieri della prima linea, vincendo, prima ancora che gli Aretini, la propria paura, ciò che ha costituito per lui, cristiano virile, un secondo battesimo e un viatico per la vita futura. Egli si adatta a vivere da esiliato dalla sua patria ma non da disertore della vita. Sa che non vale perdersi nei sogni della giovinezza, per quanto belli e vestiti a festa li possa far apparire la poesia: bisogna vivere, e dare un senso alle proprie giornate. Sensibile e profondo fin da giovane, comprende che non è il solo talento, che pure sa di possedere in sommo grado, che fa l’uomo, ma le scelte morali, che ai sogni e al talento offrono una corona immarcescibile.
Ma bisogna che Eros, questo millantatore, questo professionista della menzogna, ceda il passo, nell’anima sempre disposta all’illusione, ad Agape, l’amore di Dio che non illude, «luce intellettual piena d’amore» (Par., xxx, 40), il solo in grado di dare ai vaganti frammenti della memoria un punto di gravità permanente e alla vita, che è sempre milizia, una durevole direzione di marcia.
Dante apprende a sue spese che se Eros è figlio della mancanza, del vuoto, come insegna Platone (428/27 a.C.-348/47 a.C.), la poesia, quando è autentica, è sempre figlia, nella gioia e nel dolore, della pienezza della vita.
Beatrice, figura reale, in carne ed ossa, come si diceva, diviene così la fonte permanente dell’ispirazione artistica del poeta fiorentino, l’anello di congiunzione dei suoi capolavori, scritti in volgare, perché bisogna spezzare con il popolo il pane della conoscenza: Vita nova, Convivio, Commedia, capitoli di un unico libro cuciti assieme dal filo rosso di una passione che è umana e divina.
Beatrice diventa, nella penna sublime di Dante, la forma umana di quello stesso “amor che move il sole e l’altre stelle” (Par., XXXIII, 145): l’affascinante ragazza che molti anni prima gli aveva rivolto lo sguardo facendolo trasalire, e che lui collocherà sì nel terzo giro della mistica rosa dell’Empireo, «nel trono che i suoi merti le sortiro», ma solo dopo averla collocata nel fondo del suo cuore di poeta. Ciò non deve stupire. Le biografie di molti uomini di talento delle epoche passate ci mostrano come all’origine di ogni grande creazione artistica, sia essa opera letteraria o musicale, dipinto o saggio originale di pensiero, c’è spesso un incontro fatale con una donna, destinata a fungere da musa ispiratrice in un rapporto che non necessariamente, anzi quasi mai, implica l’erotismo; eppure ha a che fare con un corpo, per quanto spiritualizzato esso possa essere: un legame sentimentale profondo che può persino assumere i contorni di un’esperienza mistica, per quanto incompleta e contraddittoria essa possa apparire.
Si potrebbero citare infiniti esempi a tale riguardo. Basti ricordare il celebre incontro, divenuto proverbiale, di Petrarca con Laura in Avignone o ciò che, qualche secolo più tardi, scriverà William Wordsworth (1770-1850), poeta romantico per eccellenza, a proposito di una ragazza incontrata in una campagna della Scozia mentre mieteva il grano e intonava una canzone dalle note strazianti.
Egli dirà che porterà questa scena sempre nel suo cuore, a rinfocolare in ogni momento della sua vita una fervida vena lirica.
Ogni vero poeta deve avere la sua musa, che sia l’immagine di un volto contemplato nella giovinezza e che di tanto in tanto torna a visitare i suoi sogni nelle notti d’inverno, o che si tratti – meglio ancora – della donna che da quaranta anni gli sta a fianco e che gli fa da visibile angelo custode.
Come ogni uomo, Dante parla ai suoi contemporanei, come ogni grande parla attraverso i secoli: ci libera dal provincialismo dei sentimenti, ci invita ad impegnarci nell’attualità ma a non lasciarci irretire dalle sue miserie, dalle convenienze e dalle mode, puntando piuttosto ad essere contemporanei dell’eterno.
Leggere Dante significa assimilarne la lezione, essere disposti a trasformarci, ad aprirci alla dimensione dello spirito, a fare ogni giorno i conti con la vita in rapporto con il nostro dovere (di coniugi, di genitori, di cittadini operosi) e con la morte che ci attende: morte, giudizio, inferno, paradiso, come ci insegnavano al catechismo quando eravamo bambini e come non si insegna più.
Leggere Dante significa scegliere ogni giorno se lasciarci guidare in un cammino di salvezza, contro le nostre pigrizie e il nostro egoismo, o sprofondare negli abissi della perdizione.
Scegliendo Dante, inoltre, si sceglie il bello, e così, inevitabilmente, si finisce tra le braccia dell’assoluto, cioè del bene e del vero.La Divina Commedia è il Poema della Bellezza, di cui
La Vergine Maria è l’espressione più altamente divina e Beatrice l’incarnazione umana: due donne che ben possono simboleggiare la teologia e la filosofia, come le intendevano quegli uomini del Medioevo affamati di Dio e di sapere.
Giovi a questo proposito riportare le parole che un papa dimenticato ma che fu grande, Paolo VI (1897-1978), che di bellezza si intendeva, scrisse nel 1965 in una lettera apostolica nella quale commemorava il grande poeta in occasione del settimo centenario della sua nascita:

«La teologia e la filosofia hanno con la bellezza un altro rapporto consistente in questo: che prestando la bellezza alla dottrina la sua veste e il suo ornamento, con la dolcezza del canto e la visibilità dell’arte figurativa e plastica, apre la strada perché i suoi preziosi insegnamenti siano comunicati a molti. Le alte disquisizioni, i sottili ragionamenti sono inaccessibili agli umili, che sono moltitudine, essi pure famelici del pane della verità; senonché anche questi avvertono, sentono e apprezzano l’influsso della bellezza, e più facilmente per questo veicolo la verità loro brilla e li nutre.
E’ quanto intese e fece il signore dell’altissimo canto, a cui la bellezza divenne ancella di bontà e di verità, e la bontà materia di bellezza».
La Divina Commedia è tante cose (basti pensare a quale scrigno di sapienza linguistica essa contenga), ma è soprattutto – come si diceva – la storia di una promessa d’amore umano mantenuta e una sfida divina accettata, il «poema sacro, – al quale ha posto mano e cielo e terra, – sì che m’ha fatto per più anni macro» (Par. XXV, 1-3): l’opera di una vita che ha letteralmente consumato il suo autore, testo che sfugge ad ogni classificazione di genere, unico nel panorama letterario di ogni tempo.
La lingua e la cultura umanistica italiana hanno in Dante Alighieri il suo padre nobile e nella bella figlia di Messer Folco Portinari la sua inconsapevole ma vera madrina. Tutto fu deciso in quel Venerdì Santo dei primi di aprile del 1300.
Ma tutto si deve a quella ragazzina incontrata dal poeta all’età di nove anni in una stradina di Firenze e poi rivista, giovane sposa, in un luminoso pomeriggio, e che l’aveva catturato per sempre con quei «belli occhi onde a pigliarmi fece Amor la corda» (Par., 28, 11-12). Che cosa può mai fare una donna di un uomo innamorato! Sprofondarlo all’inferno o condurlo per mano in Paradiso.
Redazione Corriere di Puglia e Lucania