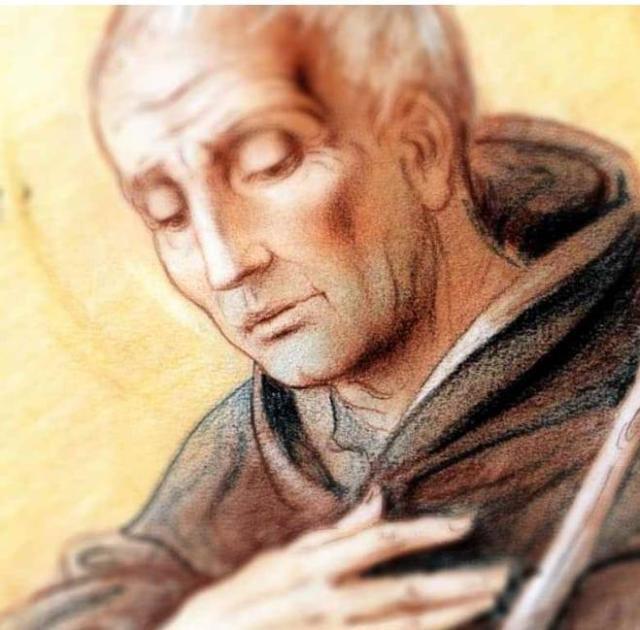La prima al Piermarini. Il re di Spagna fra ossessione di potere, repressione dei popoli e solitudine come il leader russo. E potrebbe cantare: «Sono gli ucraini a me ribelli»
Chissà che cosa accadrebbe se questa sera al teatro alla Scala di Milano, durante la prima di Don Carlo che inaugura la stagione, si sentisse il fedele consigliere del re rivolgersi al despota con queste parole: «O signor, di Ucraina arrivo, quel paese un dì sì bel; d’ogni luce or fatto privo spira orror, par muto avel! L’orfanel che non ha un loco per le vie piangendo va; tutto struggon ferro e foco, bandita è la pietà». E l’autocrate rispondesse: «Volgi un guardo alle Russie!
La pace istessa io dono alla mia Ucraina!». Poi l’interlocutore del dittatore gli controbattesse «con impeto», come si legge nella didascalia: «Orrenda, orrenda pace! La pace è dei sepolcri! Il popol geme. S’ode ognun a Vladimiro maledir!». O ancora se, nella scena di popolo intorno al sovrano con il rito dell’autodafé, la folla cantasse: «Il mondo è prostrato al suo piè! Il suo nome è l’orgoglio della Russia, e viver deve nell’eternità!». E lui, poco dopo, gridasse con la voce da basso: «Sono gli ucraini a me ribelli». Sì, tutto è solo immaginazione. E un gioco. Di poche parole sostituite al libretto messo in musica da Giuseppe Verdi: “Ucraina” al posto di “Fiandre”; “Russia” al posto di “Spagna” (o Spagne); “Vladimiro” al posto di “Filippo”, il tiranno del Cinquecento che è uno dei sei protagonisti del titolo in scena al Piermarini. Per il resto nessun’altra variazione. Eppure ad ascoltare la “grand opéra” e a leggere il testo che scorrerà sui display del teatro o sulle tv collegate in tutto il mondo con il capoluogo lombardo si potrà essere come proiettati verso l’ultima guerra che insanguina l’Europa: quella fra Russia e Ucraina.
E nel re di Spagna, nella sua sete di conquista, nel suo desiderio di vendetta, nel suo imperialismo assolutista scorgere l’attuale inquilino del Cremlino che ha voluto l’invasione del vicino Paese. A dire l’attualità di un’opera che, come ha spiegato il direttore musicale della Scala, Riccardo Chailly, sul podio questa sera, racconta il potere “malato” e chiude la «trilogia dell’oppressione» al centro degli ultimi 7 dicembre iniziata con Macbeth nel 2021 e proseguita con Boris Godunov lo scorso anno. Tre ore di musica a tinte fosche, nella versione rielaborata da Verdi per la Scala, che sono un viaggio fra il «guazzabuglio del cuore umano», si direbbe con Manzoni, attraverso i conflitti, le ambiguità, le tortuosità psicologiche, l’intreccio fra bene e male. Ecco perché, a un certo punto, viene da chiedersi se gli spasmi dell’animo, la solitudine, i dubbi che assalgono Filippo II, e che il genio del melodramma scolpisce nella sua imponente e complessa partitura, siano gli stessi che segnano chi ha fatto dei soprusi, della violenza e delle armi la sua ragione d’essere.
Anzi, viene quasi da sperarlo. Soprattutto se si abitano le segrete stanze di Mosca e si fa di cognome Putin. La sua solitudine è già apparsa in più occasioni. L’ossessione per i tradimenti e le congiure – evidenti in Don Carlo – anche. Ma avrà i tormenti di Filippo? Comunque il re è nudo e fragile nonostante indossi la corazza della possenza pubblica, come nel capolavoro verdiano testimonia il drammatico dialogo del monarca con il Grande Inquisitore. E dall’opera emerge anche un’altra pericolosa dimensione: l’alleanza fra «trono» e «altare». Purtroppo ben presente intorno all’odierno “zar”: con la benedizione della guerra e un patto di mutuo sostegno ammantato d’incenso. «Le religioni non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue», ricorda la Dichiarazione di Abu Dhabi firmata nel 2019 da papa Francesco e dal grande iman di Al-Azhar
Il documento si chiama della “fratellanza umana”. Allora appaiono stonate le dichiarazioni di Lluìs Pasqual, regista scaligero di Don Carlo, che alla presentazione della nuova produzione ha definito «la religione e il nazionalismo» le «peggiori sciagure inventate dall’uomo per rifiutare l’altro». Certo ardore ideologico non può trovare cittadinanza accanto a un compositore che, benché si considerasse «un po’ ateo», ha dato «l’esempio – scriveva Arrigo Boito – della fede cristiana per la commovente bellezza delle sue opere religiose, per l’osservanza dei riti (devi ricordarti la sua testa abbassata nella cappella di Sant’Agata)» perché «sapeva che la fede è sostegno dei cuori».
Marcario Giacomo
Editorialista de Il Corriere Nazionale